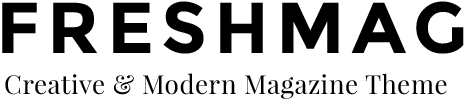Per una lingua che non sia stereotipata

Nel 1949, nel suo celebre romanzo 1984, Georges Orwell immagina uno stato totalitario, Oceania, dotato di un ministero della verità e di una polizia del pensiero, che ha istituito un linguaggio mirante a ridurre per la sua popolazione il campo possibile del pensiero: la neolingua. A questo fine, il lessico della neolingua è molto ridotto ed è riorganizzato in tre classi A, B, e C. Il vocabolario A contiene solo i termini necessari al lavoro e alla vita quotidiana, la cui univocità impedisce ogni uso letterario, politico o filosofico. Il vocabolario B contiene delle parole composte, dei nomi-verbi costruiti a fini politici. Il vocabolario C è specialistico e interamente composto di termini scientifici e tecnici. Infine, la grammatica della neolingua si caratterizza per l’intercambiabilità tra le parti del discorso e la sua regolarità: la regola grammaticale non conosce più eccezioni.[1]
Nella nostra epoca, quella del neocapitalismo, dell’estensione del management in tutti gli ambiti professionali e umani, delle guide di “buone pratiche” decretate come leggi, del trionfo delle lobby e dello storytelling, occorre constatare che la lingua, in molti settori professionali e anche oggi nella vita di tutti i giorni, si trova contaminata da termini e formulazioni che pretendono di garantire, con il loro tecnicismo affettato, una maggiore oggettività. Le donne delle pulizie oggi sono dunque dei “tecnici delle superfici”, i venditori dei “consiglieri”, i bigliettai degli “incaricati della clientela”, gli impiegati dei “collaboratori”, i “ciechi” dei “non vedenti”, gli handicappati dei “portatori di handicap”, gli autistici delle “persone con autismo”, i vecchi delle “persone anziane” e – colmo dei colmi! – i piani di licenziamento dei “piani di salvaguardia dell’impiego”. Così, a immagine del “nostro mondo tecnocratico [che] dissimula la sua freddezza sotto la demagogia del cuore”, come formula Milan Kundera,[2] queste formule standardizzate hanno di mira, sotto un’apparenza di oggettività, la massima neutralità, ciò che riesce a dire, con il maggior numero di parole, meno cose possibili. Così, a forza di prudenza, esse finiscono per evitare del tutto l’oggetto che dovrebbero designare, talvolta sembrano perfino designare il suo contrario, e alla fine non designano più niente. Per Pierre Bourdieu, il sistema scolastico “insegna non solo un linguaggio, ma un rapporto con il linguaggio che è solidale con un rapporto con le cose, un rapporto con gli esseri, un rapporto con il mondo completamente derealizzato”.[3]
La letteratura, al contrario, testimonia da sempre di uno sforzo di dire da vicino e il più precisamente possibile come un soggetto percepisce il mondo, che cosa sente e che cosa vive. La specificità dello scrittore è trasgredire le regole, creare forme nuove e reinventare che cos’è un testo, mettere in questione il senso e la funzione stessa della scrittura. La storia letteraria è costruita su queste invenzioni fuori-norma che talvolta, nella loro epoca, sono sembrate aberranti o scandalose. Essa testimonia di una riflessione incessante degli autori sulla forma e la materia stessa del testo. Ognuno dei grandi nomi della letteratura ha intaccato la lingua della sua epoca, ha fatto passare nella lingua la sua invenzione, la sua enunciazione, il modo in cui ha manipolato la lingua giocando con le parole, i suoni, gli spazi bianchi, la puntuazione, per dire il suo mondo. Si pensi al verbo tuonante di Hugo, alle costruzioni formidabili di Flaubert, allo stile affilato di Gide, alla scrittura parlata inimitabile di Céline, alla scrittura intinta nell’acido di John Fante, alla ricerca sinestesica di Rimbaud, all’uso del silenzio in Mallarmé, alla scrittura vorticosa e multilingue di Joyce, all’onirismo di Garcia Marquez, alla lingua allucinata di Burrough, all’inventiva dei Surrealisti e alla loro Officina di Letteratura Potenziale, alla lingua offensiva di un Bataille, alla scrittura onomatopeica e che risuona di un Gerashim Lucas, a Duras e alla sua scrittura cinematografica, alla lingua magnifica di un Senghor o di un Kateb Yacine per i quali la lingua era innanzitutto un’arma politica, a Marina Tsevateieva per cui doveva essere la vita stessa, un “viviscrivere”, a molti altri… Per Sartre i poeti sono uomini che rifiutano la funzione utilitaristica del linguaggio, la parola in poesia non rinvia all’oggetto ma lo incarna: “[…] il poeta si è ritirato di colpo dal linguaggio-strumento; ha scelto una volta per sempre l’atteggiamento poetico che considera le parole come cose e non come segni”.[4] E come scrive Barthes nella prefazione a Eden Eden Eden di Guyotat (la cui affissione, pubblicità e vendita ai minori furono vietate dal Ministero dell’Interno quando uscì nel 1970), questo lavoro sulla lingua apre a una nuova mimesi il cui modello “non è più l’avventura di un eroe, ma l’avventura stessa del significante: quello che gli accade”.[5]
Jacques-Alain Miller, nel suo corso del 2002-2003, invitava gli psicoanalisti a fare “uno sforzo di poesia”.[6] Il lavoro analitico invita in effetti ad uno sforzo di ben dire. Come analizzante si tratta di riuscire a dire il più vicino possibile al reale, di isolare i significanti tessendo il filo rosso di ciò che ci è più singolare, di dire il più precisamente possibile, con il minor numero di parole, ciò che tocca nel più intimo al fine di bloccare ciò che vi sfugge, che passa tra, il godimento che abita e agita i nostri corpi viventi e parlanti. In questo, nella nostra epoca la parola analitica è una parola resistente. Smentisce il principio dell’“utilità diretta”[7] alla quale siamo quotidianamente votati. Non si lascia nemmeno ridurre a una parola scientificizzata e pretesa oggettiva, scavata e svuotata della sua sostanza vivente. Per apportare un soffio d’aria pura in quest’era contabile dagli accenti kafkiani, dove la valutazione estende il suo dominio, dove l’algoritmo è re, questa rubrica si farà eco di tutti gli sforzi di creazione fuori norma in materia di linguaggio scritto e parlato: visiteremo i luoghi e i tempi in cui gli uomini hanno fatto e fanno ancora e sempre questo necessario sforzo di parola per dire, al di là dell’universale del linguaggio, il loro rapporto singolare con l’altro e con il mondo.
Traduzione di Francesca Carmignani
Revisione di Maria Bolgiani
[1] G. Orwell, I princìpi della neolingua, annesso a 1984, Mondadori, Milano 1950.
[2] M. Kundera, lettera a Philippe Solers, L’infini n. 25, marzo 1989.
[3] P. Bourdieu, Intervento al Congresso dell’AFEF, Limoges, 30 ottobre 1977.
[4] J.-P- Sartre, Che cos’è la letteratura ?, Il Saggiatore, Milano 1960.
[5] P. Guyotat, Eden Eden Eden, Paris, Gallimard, 1970, prefazioni di Michel Leiris, Roland Barthes et Philippe Sollers.
[6] J.-A. Miller, Un effort de poésie, corso dell’anno 2002-2003, pronunciato nel quadro del Dipartimento di Psicoanalisi di Parigi 8.
[7] J.-A. Miller, Un effort de poésie, lezione del 5 marzo 2003, pronunciata nel quadro del Dipartimento di Psicoanalisi di Parigi 8.
This post is also available in: FranceseIngleseSpagnoloOlandese