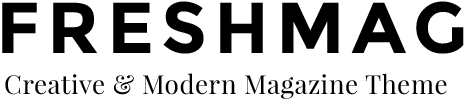La soluzione con i muri

La dimensione del patto, che è il fondamento di ogni legame, oggi è piuttosto precaria. Viviamo in una società globalizzante e asociale. Le conseguenze soggettive di questo processo di isolamento, le ascoltiamo nei lamenti dei soggetti, presi uno per uno, nei confronti della solitudine e della precarietà dei legami.
Fin dal 1967 Lacan aveva proposto un’interpretazione di tali fenomeni quando, riferendosi ai campi di concentramento, dice: « […] quanto ne abbiamo visto emergere, con nostro orrore, rappresenta la reazione di precursori rispetto a quantoi si andrà sviluppando come conseguenza del rimaneggiamento dei raggruppamenti sociali a opera della scienza e, per chiamarla per nome, dell’universalizzazione che la scienza vi produce. Il nostro avvenire di mercati comuni avrà come contrappeso una sempre più dura estensione dei processi di segregazione».[1] La segregazione è diventata uno tra i modi nuovi di trattare le differenze. Lo psicoanalista non può ignorare tali fenomeni, ciò che sta al principio dello scioglimento del legame, che, a partire da «Radiofonia»[2], Lacan metteva in rilievo come ciò che non si scrive tra i sessi, ripreso in seguito nel suo insegnamento con la formula «c’è dell’Uno».[3] Nella nostra società fondata sui diritti dell’uomo, si denuncia la segregazione e si cerca di combatterla, ma non si riesce, o molto male, a causa della radice comune inconscia della segregazione, che è soggettiva. Da questo punto di vista si potrebbe dire che lungi dall’essere soltanto imposta, la segregazione è scelta.
Lacan fornisce la chiave dell’opzione segregativa quando parla del «razzismo dei discorsi in azione»[4]. I discorsi costruiscono delle razze di godimento che, come i sintomi individuali, presiedono a ciò che scegliamo e a ciò che rifiutiamo. Il capitalismo globalizzante, in accordo con la scienza, produce effetti di precarietà delle identità sociali e fa crescere, di conseguenza, le rivendicazioni identitarie. Ma restiamo qui nel campo delle identità, delle alienazioni che ci vengono attribuite dall’Altro. Per ciò che concerne una identità singolare, conseguenza della presenza in noi dell’inconscio reale, che mette in questione l’identità che ciascuno si attribuisce, essa non ha alcun legame intrinseco con la segregazione, sempre sociale. Coloro che domandano un’analisi si lamentano spesso che la loro identità non sia riconosciuta, o al contrario si lamentano di essere assoggettati a categorie sociali identitarie e segregative che li situano dal lato della norma o dell’atipico. Per questo è indispensabile dall’inizio operare una rettifica della supposta identità, di metterla in causa per fare posto al soggetto supposto, al «ça parle» dell’inconscio che fabbrica i propri sintomi.
[1] J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 255
[2] J. Lacan, Radiofonia, Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 399
[3] J. Lacan, Le Seminaire livre XIX …ou pire, Editions du Seuil, Paris 2011, p. 137
4. J. Lacan, Televisione, Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 505
This post is also available in: Francese