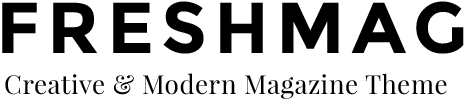Un Altro troppo buono

Quando gli si domandava com’era la sua nuova scuola, egli rispondeva immediatamente: « è molto, molto grande ! », che era tutt’altro dall’essere un dato oggettivo del luogo stesso. Per contro, diceva molto della sua esperienza soggettiva. Durante i primi tempi nella nostra istituzione specializzata, si occupava di esplorare tutti gli angoli del luogo, di inserirsi in tutte le attività e di farsi presente a tutti gli operatori così come a tutti bambini, di età diverse, che erano nell’istituzione. Tali percorsi ingrandivano il suo spazio soggettivo.
Il suo giudizio errato, quanto alla dimensione del luogo che mettiamo a sua disposizione, non era nient’altro che la constatazione di un paradosso: con i bambini che presentano alcuni tipi di difficoltà a passare attraverso legame sociale comune, le buone intenzioni dell’Altro sociale – si legga, le intenzioni sincere d’includerlo e d’integrarlo- possono arrivare a produrre una segregazione molto più radicale di quella che espelle dall’istituzione scolastica (cosa che era ancora di attualità fino a qualche anno fa per i bambini giudicati inadatti ).
Poiché a forza di adoperarsi per mantenere il soggetto nel suo ambito, si finisce per condannarlo all’isolamento all’interno di quello stesso luogo in cui lo si mantiene; a questo si aggiunge una sorveglianza, sempre più spinta ai limiti, di tutto ciò che fa e di tutti i gli scambi con i suoi simili.
Così era stato per questo soggetto di nove anni. Il suo ultimo anno scolastico si era svolto in una piccola stanza della sua scuola elementare, accompagnato costantemente da un solo adulto, sempre lo stesso, la cui funzione è chiamata, in Spagna, sorvegliante – colui che deve vegliare sul bambino, come si veglia su un malato.
Nel nostro sistema educativo, si afferma l’uguaglianza delle possibilità offerte a tutti i bambini, prendendo come orientamento l’ideale dell’inclusione e dell’integrazione. Si tratta di un tutti uguali che, senza alcun dubbio, racchiude una forte carica di buona fede: cosa che, come afferma Lacan, lungi dal diminuire il peso della sua colpa, la rende ancora più imperdonabile.[1]
Per i bambini che non riescono a essere sufficientemente simili agli altri, questo ideale benevolo di inclusione – e soprattutto le esigenze soggiagenti che contiene – diventa un imperativo terribile e invasivo, che si trasforma in un terreno perfetto per nutrire le fobie e i passaggi all’atto, come unici modi per affrontare l’angoscia che questo Altro con le sue intenzioni troppo buone produce. Da troppo buono egli diventa cattivo, persecutore.
La nostra società pretende che i soggetti si sottomettano – e se possibile in silenzio – alle identificazioni che gli sono generosamente offerte. È il regno di ciò che Lacan ha chiamato « il bambino generalizzato », colui che ha perso la sua singolarità per essere ridotto al rango di oggetto come gli altri: classificato, studiato, etc. Di conseguenza, ciò implica « l’entrata di un intero mondo nella via della segregazione »[2] poiché, la segregazione, è convertire un soggetto in un oggetto incluso in un programma. Anche il programma buono!
Traduzione Elena Madera
[1] Lacan, J., « La scienza e la verità », Scritti, Einaudi, Torino 1974.
[2] Lacan J., « Allocuzione sulle psicosi infantili », in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p.365.
This post is also available in: FranceseIngleseSpagnoloOlandese