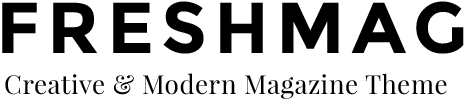L’essere sessuato non si autorizza che da se stesso…e da qualche altro

Disforia di genere è la diagnosi che, nel DSM-V, “si riferisce alla sofferenza che può accompagnare l’incongruenza tra il genere esperito o espresso da un individuo e il genere assegnato”[1] sostituendo il disturbo dell’identità di genere del DSM-IV.
I criteri diagnostici per la Disforia di genere sono specificati nei bambini, negli adolescenti e negli adulti. In ogni caso, l’incongruenza tra genere esperito e genere assegnato deve durare da almeno 6 mesi e i criteri con cui si manifesta, per bambini e adolescenti, vanno dal desiderio o l’affermazione di appartenere al sesso opposto, alla preferenza dell’abbigliamento, e/o il travestimento, dei ruoli, dei giochi, dei giocattoli, delle attività, dei compagni sessuali del genere opposto, all’avversione per la propria anatomia sessuale e al desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie del genere esperito; mentre per gli adulti i criteri si elencano in varie declinazioni dell’incongruenza tra genere esperito e/o espresso e quello atteso e/o desiderato.
La disforia di genere è considerata indipendente dall’orientamento sessuale, anche se si constata che i bambini/e che mostrano una persistenza sono attratti da individui dello stesso sesso “di nascita”. La disforia di genere riguarda infatti l’ego, l’identità. Il film The Danish Girl di Tom Hooper, basato su una storia vera, ci mostra come l’identità staccata dal desiderio e dal godimento possa essere pericolosa. Lili Elbe, nata Einar Wegegener, “sente” crescere dentro di sé una nuova identità femminile e, con l’aiuto della moglie con la quale fino a quel momento aveva condiviso una vita d’artista, decide di sottoporsi a diversi interventi di riassegnazione sessuale. Il film, sulla scia del movimento LGBTIQ[2], sostiene l’eroica pioniera che, a costo della morte – nella realtà avvenuta al quinto intervento, di impianto dell’utero – con l’aiuto di un medico che è entrato nel suo delirio, ha cercato di conseguire la sua massima aspirazione: una donna che poteva avere dei figli.
Ma proprio il termine “disforia” utilizzato in psichiatria per indicare un’alterazione dell’umore in senso depressivo, è sintomo del ritorno del grande rimosso di questa classificazione: l’oggetto. Come Freud ci insegna, nella malinconia l’ombra dell’oggetto cade sull’io, l’io si identifica all’oggetto perduto e subisce la riprovazione della coscienza morale. La dysphoría ci indica una mancanza che riguarda l’oggetto e non l’io. Il DSM-V nota inoltre che tra le bambine “nate femmine” si riscontra il desiderio di avere un pene, o affermare di possederlo o che che più tardi crescerà. Un’affermazione che ci ricorda qualcosa… Così Freud descrive la risposta della bambina alla scoperta della differenza sessuale: “Essa l’ha visto, sa di non averlo, e vuole averlo”[3]! Più tardi la constatazione della propria evirazione conduce la bambina a diverse possibili soluzioni, una delle quali è il “complesso di mascolinità” che può sfociare nella scelta omosessuale[4]. Desiderio, scelta d’oggetto e desiderio sono la bussola che orienta la psicoanalisi e sostiene il soggetto nell’assunzione del proprio sesso.
S., nata con un disturbo della differenziazione sessuale, ha subito una prima operazione nella prima infanzia, è cresciuta come bambina e come ragazza. Da adulta ha deciso per un’operazione che l’ha dotata di una vagina. S. non ha mai avuto dubbi sulla sua identità sessuale, ma dopo l’operazione si apre per lei l’interrogativo di che cosa significhi essere donna, che cosa la rende donna. Interrogativo su cui non cessa di spaccarsi la testa, finché non si rende conto che il quesito è indecidibile, perché un’identità sessuale femminile non ha una consistenza e che l’unica risposta la può trovare attraverso l’incontro con l’Altro che le si presenterà nelle contingenze della vita.
La soluzione del gender, così nel DSM 5 come nelle rivendicazioni del movimento LGTBQ, va nel senso di una auto-nominazione: ognuno sceglie il sesso che desidera, sia attraverso la soluzione legale che attraverso quella medico-chirurgica. La soluzione psicoanalitica è diversa: per Lacan “l’essere sessuato non si autorizza che da se stesso…e da qualche altro”[5], si tratta di una nominazione che include l’Altro in cui il soggetto ha riposto i propri oggetti e da cui dipende.
[1] American Psychiatric Association, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta edizione, DSM-5®. Edizione italiana a cura di Massimo Biondi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 528.
[2] LGBTIQ: Lesbien, Gay, bisexual, transgender, Queer.
[3] S. Freud, Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica tra i sessi, Opere, vol. X, p. 211.
[4] S. Freud, Sessualità femminile, Opere, vol. XI, p. 67.
[5] J. Lacan, Les non dupes errent, lezione del 9 aprile 1974, inedito.